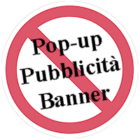La scuola, oggi

“E che ne sarà di tutti i ragazzini che non si pettinano mai?”, si chiedeva Tom Waits in uno dei suoi capolavori degli anni ’70. Non lo so, nessuno lo sa. Ma andare a scuola spettinati penso sia il primo innocente segnale di uno spirito rock and roll. Come a dire: “Ok io qui imparo tutto e prometto che studio, ma per il resto non ditemi cosa devo fare perché ci voglio arrivare da solo”.
Resta il fatto però che tra la scuola che ho fatto io e quella di oggi ci sono almeno venti abissi. Al di là dei proclami e dei patti educativi, troppo spesso la scuola si risolve in una prosecuzione della materna che livella e normalizza. Sicuramente si sforza di includere, ma spesso finisce per appiattire quella diversità che pretende di esaltare. Non si riesce a star dietro a quelli in difficoltà, figuriamoci a quelli bravi. Ma qui la polemica non è banalmente rivolta ai genitori iperprotettivi o ai docenti che si esprimono in un italiano stentoreo. Bensì a chi sta sopra: alla politica, che decide cosa bisogna insegnare e perché.
Parto da una facile constatazione: nemmeno il 10% degli adulti finisce per fare il lavoro per cui ha studiato, anzi, spesso ci si ritrova a fare un lavoro che all’inizio del percorso scolastico nemmeno esisteva e in più le università sono ormai diventate più facili delle superiori (la laurea non è più un traguardo, al limite è l’ultima fila libera di un parcheggio). Inoltre, quando si diventa adulti, si scopre che la vita non premia il 6 in tutte le materie, ma il 10 in una sola (sempre che si sia fortunati). Quindi il punto nodale è: quali sono i buoni motivi per cui andare a scuola? Quanto vale la pena impegnarsi? Evidentemente per acquisire la cassetta degli attrezzi coi quali far fronte alle avventure e sventure della vita, personali e professionali. Il primo problema è sopravvivere. Punto.
Diventa subito chiaro che questa cassetta degli attrezzi deve avere a che fare con obiettivi e prospettive, con direzioni e relazioni. E ciò non può prescindere da una visione del mondo. La quale deriva dalla politica, dietro alla quale c’è sempre più spesso l’economia. In più ci sono tante sfaccettature e finestre quante sono le teste degli insegnanti. Il risultato è che, per quanto si sfumino i contorni, la scuola finisce sempre per dare un modello educativo e valoriale. E qui cominciano i problemi, perché ormai tutto si riduce a feroci contrapposizioni ideologiche che calpestano l’opinione opposta alla propria – e a farne le spese sono sempre i ragazzi – acuite dal fatto che taluni pretendono di entrare nella sfera intima e personale dello studente proponendo corsi non meglio specificati sull’affettività. Non meno significative sono le incursioni allarmiste che ossequiano l’economia delle emergenze, dove mere ipotesi vengono presentate come dogmi illustrati in modo così raffazzonato e superficiale che fanno rizzare i peli ai genitori.
Bisognerebbe provare a fare un esercizio: ripensare alla propria esperienza scolastica come si pensa a un lavoro precedente o a una storia d’amore. Cosa mi ha lasciato? Cosa mi ha rubato? Come mi ha arricchito, cambiato, deluso, eccitato? E via così fino a spremere la polpa dei ricordi più significativi, delle personalità più forti, delle incomprensioni più dolorose, delle gratificazioni più sincere. E spesso accade che ci si trovi a dire che, fosse stato per noi, la scuola sarebbe stata completamente diversa. Più aderente alla nostra visione. Che è, lo ripeto, una visione politica, anche se difficilmente usavamo quel termine a 16 anni. La mia è molto semplice: Dio, Patria, Famiglia, Comunità, Autodeterminazione dei popoli, Servizio militare e civile, Economia di prossimità, Welfare sanitario e previdenziale, Moneta nazionale, Iniziativa privata e libero mercato con barriere antitrust, Decentramento amministrativo fondato sulla sussidiarietà, Neutralità bellica internazionale, Cultura della vita, Sicurezza e Sovranità, No Gender e No Woke. Mi definisco, con ossimoro degli anni ’30 del secolo scorso un rivoluzionario conservatore. Ma per i dettrattori attuali sono più probabilmente un medievale, reazionario, clerico-fascista. La mia scuola scommetterebbe tantissimo sulle materie umanistiche: letteratura e lingue (antiche e moderne), storia, geografia e geopolitica, filosofia, arte e musica, sport, educazione civica (la Costituzione), sociologia, psicologia, comunicazione. Perché queste sono le materie attraverso le quali rifornirei menti libere e aperte in grado di rispettare se stesse e quelle altrui, abili al confronto, all’analisi, al giudizio critico, al pensiero sistemico, alla scelta consapevole, alla negoziazione cooperativa, all’intelligenza emotiva, alla capacità di discernere tra informazione e manipolazione, alla creatività e al problem solving. Perché coltivo l’idea che una mente elastica sia una mente che innanzitutto sa dialogare col proprio cuore, e solo le materie umanistiche possono offrire l’allenamento corretto.
Però è altrettanto vero, e qui mi rivolgo agli addetti ai lavori, che si apprende anche “in negativo”, cioè dagli esempi cattivi, dal vuoto che ci sprona a riempirlo con la nostra intraprendenza. Mi sono occupato per molti anni di formazione manageriale e, oltre a dover fare i conti con l’andragogia (l’apprendimento degli adulti), ho capito come certe competenze trasversali come il rapporto capo-collaboratore, centrali per lo sviluppo di una personalità lavorativa adatta al gioco di squadra, si possano imparare solo vivendo casi concreti e molto spesso costruendo una risposta positiva dove la realtà rimandava l’opposto. Per cui si fa in ogni caso fatica a definire quanto di profondamente nostro ci sia anche nella scuola che non avremmo voluto frequentare. Resta il fatto che la scuola deve sostenere il progetto che ogni uomo possa costruirsi la propria libertà interiore ed esteriore, esercitando la riflessione critica sul mondo in cui vive e la nettezza dialettica per sostenere le proprie idee.
Per cui una scuola che, come spesso accade oggi, dichiara come proprio fine il farti trovare un lavoro, a meno che non sia una scuola dichiaratamente professionale, è una scuola che, secondo me, mente, che si deresponsabilizza, che finge di chiamarsi fuori. In realtà non fa che considerare il giovane come strumento tra gli strumenti, non come uomo senziente e intelligente, a tutto vantaggio di prospettive iperliberiste o internazionaliste. Le prime interessate ad allevare mandrie di consumatori competitivi e creduloni (pallido retaggio di una borghesia in disarmo e fieramente capitalista anche se ormai ridotta al “voglio, ma non posso”), le seconde interessate a produrre fanatici dell’ambiente, del radicalismo avaloriale, del migrazionismo acefalo e della soppressione delle differenze culturali (pallido retaggio della cultura comunista mixata con quella hippy).
Io sono per una terza via, dove le parole sociale/nazionale e rivoluzione/conservazione non costituiscono antitesi incomunicanti, ma testimonianze di un approccio fecondo e dinamico alla realtà in cui i cittadini sanno da dove vengono e chi sono e proprio per questo sanno rispettare e integrare, ma allo stesso tempo difendere e custodire. E resto convinto, nonostante la decadenza che mi circonda, che proprio alla scuola competa ancora di preparare il terreno per una tale semina.