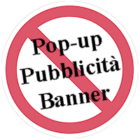Due soli al crepuscolo

Two Suns in the Sunset è il brano che chiude l’album The Final Cut del 1983, ultimo lavoro dei Pink Floyd con Roger Waters ancora nella band, autore unico delle musiche dell’intero disco.
Il testo, fortemente evocativo, esprime la paura angosciante di un conflitto nucleare globale, la sfera infuocata di un’esplosione atomica diventa metafora di due soli al tramonto, un’immagine potente e inquietante.
Roger Waters, orfano di un padre ucciso dai tedeschi ad Anzio durante la Seconda Guerra Mondiale, è sempre stato un artista impegnato nella denuncia della brutalità e degli orrori della guerra. Già nel 1973, nel celebre The Dark Side of the Moon, affrontava questi temi con il brano Us and Them in cui un soldato riflette sull’assurdità di combattere un nemico che, in fondo, è suo simile.
Nel 1969 i Jefferson Airplane cantavano One generation got old, one generation got soul:
una generazione è diventata vecchia, un’altra generazione ha un'anima. Parole che segnavano la fine dell’era conformista e militarista e l’inizio di un nuovo spirito pacifista.
una generazione è diventata vecchia, un’altra generazione ha un'anima. Parole che segnavano la fine dell’era conformista e militarista e l’inizio di un nuovo spirito pacifista.
I giovani di allora avevano ancora il ricordo della guerra nel sangue, tramandato dai padri e dai nonni, se non vissuto direttamente. Il demone della distruzione era ancora palpabile, il fumo e le ceneri non del tutto dissolti. Era urgente creare un mondo nuovo, una nuova umanità che rinnegasse l’abominio della guerra.
Nel 1970 il film L’altra faccia del pianeta delle scimmie, riprendendo le tematiche di Kubrick nel film Il dottor Stranamore, mostrava in un lontano futuro una società di uomini mutanti con poteri telepatici che venerano una bomba atomica come divinità, con tanto di riti religiosi attorno a un altare sormontato da una testata nucleare.
Dalla crisi dei missili a Cuba negli anni ’60, risolta solo grazie a intense trattative tra USA e URSS, si comprese che un conflitto armato tra le due superpotenze avrebbe significato la fine di tutto: l’alfa e l’omega, come le lettere incise sulla bomba adorata dai mutanti nel pianeta delle scimmie. Ma l’incubo di una guerra nucleare non fu mai del tutto rimosso.
In Italia, il 24 settembre 1961, si svolse la prima Marcia per la pace e la fratellanza fra i popoli, da Perugia ad Assisi, unendo i tre filoni storici del pacifismo: social-comunista, cattolico e liberal-radicale, tutti ispirati al principio gandhiano della non violenza.
Negli Stati Uniti, fin dal 1964, Joan Baez guidava manifestazioni contro la guerra. Negli anni '70 furono innumerevoli le proteste contro il conflitto in Vietnam, denunciato anche da Bruce Springsteen nella celebre Born in the U.S.A. del 1984. Quel conflitto segnò profondamente la coscienza collettiva e aprì le porte a nuovi movimenti sociali.
Il 15 febbraio 2003 si tenne una delle più grandi mobilitazioni di massa della storia: milioni di persone, in oltre ottocento città del mondo, manifestarono contro l’invasione statunitense dell’Iraq. Il regime di Saddam Hussein era nel mirino dell’amministrazione Bush, ma le presunte armi di distruzione di massa si rivelarono una montatura. L’opinione pubblica intuì fin da subito la manipolazione dell’intelligence e che l’Iraq non aveva legami con l’11 settembre.
Negli anni passati, artisti come John Lennon (Give Peace a Chance), Bob Dylan (Blowin’ in the Wind), i Black Sabbath (War Pigs), gli Iron Maiden (Two Minutes to Midnight, che fa riferimento all’orologio dell’apocalisse), Sting (Russians), i Nomadi (Contro), Fabrizio De André (La guerra di Piero) e tanti altri hanno continuato a denunciare con parole e musica la follia della guerra.
Una follia riassunta perfettamente da Albert Einstein: «Non so con quali armi verrà combattuta la Terza Guerra Mondiale, ma la Quarta verrà combattuta con clave e pietre.»
Accordi internazionali come lo START (Strategic Arms Reduction Treaty) tra Stati Uniti e Unione Sovietica hanno cercato di limitare le armi strategiche offensive. In Italia, i movimenti pacifisti hanno ottenuto la possibilità dell’obiezione di coscienza al servizio militare (prima punita con il carcere), fino alla sua definitiva abolizione nel 2005.
La coscienza collettiva sembrava andare sempre più in una direzione volta alla pace, e quindi al disarmo. E fu anche grazie a una forte mobilitazione pacifista che, nel 1990, il Parlamento approvò la legge 185 sul commercio delle armi per impedirne la vendita a nazioni in guerra o che violano i diritti umani (legge che oggi viene sottoposta a continui tentativi di smembramento).
Eppure, nei primi mesi del 2025, ci ritroviamo immersi in un distopico ritorno al passato. Le piazze non si riempiono più per invocare la pace, ma per promuovere – con un linguaggio degno di Orwell – il riarmo europeo. Dopo il temporaneo slogan SAFE – Security Action for Europe, oggi il progetto si presenta con un nome ancora più rassicurante: Readiness 2030, ovvero Prontezza 2030.
Un rebranding studiato a tavolino dall’Unione Europea pensato per sembrare inclusivo, neutrale, persino pacifista. Ma dietro quelle parole si nasconde l’ennesima corsa agli armamenti (questa la vera denominazione, come è sempre stata): droni, missili, guerra elettronica, mobilità militare. Tutto sotto la bandiera della protezione.
E così, con buona pace di chi ha cantato la pace per decenni, oggi ci ritroviamo ad ascoltare su enormi palchi con tanto di maxischermi non solo artisti, ma anche filosofi e conduttori televisivi. Figure pubbliche che sembrano aver dimenticato, o forse rimosso, cosa significhi davvero la guerra vissuta sulla pelle delle generazioni precedenti, dai loro padri e nonni.
Si parla di libertà, di pace giusta, di deterrenza positiva, in una vera e propria manipolazione del linguaggio che trasforma la guerra in un atto di civiltà, dimenticando che oggi un conflitto globale sarebbe probabilmente fatale per l’intero pianeta.
Per la pace, ci dicono, servono i cannoni. Dobbiamo essere pronti. Certo, sempre pronti alla guerra, mai alla pace.
Forse, sarebbe il caso che questi nuovi oratori dell’Apocalisse si fermassero un attimo. E ascoltassero, dall’inizio alla fine, The Final Cut. Lo consiglio davvero, con sincerità: è un disco intenso, ricco di sfumature sonore, potente, unico. Perché in un futuro post-bellico, Roger Waters non avrà più chitarre né parole per denunciare l’orrore. Avrà solo una clava.